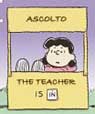La relazione protettiva
L’adulto protegge nella relazione, che si tratti della relazione genitore-figlio o insegnante-studente, quando ascolta con attenzione, con interesse, senza fraintendere, ma per volere veramente capire la comunicazione che il ragazzo dà. Questo crea le basi per la sicurezza e la fiducia.
Spesso l’adulto non ascolta perché vuole sentire solo quello che lui vuole o perché vuole modificare il ragazzo, vuole imprimere il proprio parere, la propria visione, le proprie conoscenze, le proprie nozioni.
Se si vuole proteggere veramente l’adolescente o il bambino la relazione deve essere improntata al rispetto, alla pazienza senza nessuna arroganza, senza pretese o richieste, facendo in modo che il ragazzo si senta ascoltato, più ancora che capito, che senta che gli viene dato il permesso di esprimersi senza giudizi e senza pregiudizi.
In adolescenza il rapporto con i genitori ha già una sua storia, non si crea ex-novo, molte cose sono già stabilite, irrigidite, allora occorre avere la sensibilità e la duttilità di rendersi conto che se questo rapporto è già costruito, ha delle modalità e difese costituite, occorre avere molta umiltà e disponibilità a capire la comunicazione che viene data. A volte per rigidità, o per i propri schemi si possono aver detto o fatto cose che hanno precluso la fiducia, il dialogo, generato diffidenza. Per sciogliere la diffidenza bisogna essere aperti al dialogo ponendo una regola chiara: la lealtà e l’onestà soprattutto. Stabilire un rapporto chiaro, leale, di fiducia reciproca in cui l’adulto si mostra disposto ad ascoltare, a interrogarsi, anche a piegarsi, ma non a farsi abbindolare. La fiducia va di apri passo con la lealtà e la chiarezza e deve essere basata sulla reciprocità, senza discorsi minacciosi o ricattatori.
Gli adolescenti fanno fatica ad essere chiari perché non hanno chiarezza dentro di loro, ma anche gli adulti molto spesso non hanno chiarezza perché guardano il risultato anziché porsi con disponibilità. Il risultato scolastico o il compito per il ragazzo può essere irrilevante mentre invece tutti intorno chiedono che si facciano dei compiti, cioè il dovere, ma insieme al dovere deve esserci anche la possibilità di assaporare il piacere delle cose.
Fra le condizioni specifiche dell’adolescenza e necessarie in questa fase dello sviluppo ci sono da un lato, la tendenza alla ricerca del nuovo: nuove esperienze, nuove emozioni, nuovi stimoli, nuove persone che comporta un bisogno di sperimentare anche “il rischio”.
Dall’altro lato c’è l’esperienza della solitudine, il bisogno di essere solo, sentire che si può fare da soli. Non dimentichiamo che il compito fondamentale dell’adolescente è quello separasi e individuarsi, di andare verso l’autonomia e la conquista di una propria identità. In questo percorso si trova a vivere in modo particolarmente intenso il dilemma dello sviluppo umano: individuarsi e riconoscersi come individuo separato, ma nello stesso tempo riconoscere di avere bisogno dell’altro.
Cioè il paradosso del bisogno dell’altro per poter diventare se stesso con le paure che questo comporta, come la paura di rimanere perso nella solitudine dell’indipendenza e la paura di rimanere imprigionato nella dipendenza, nei legami. Ecco allora la necessità di sperimentarsi, di provare, di prendere delle distanze nella certezza di poter tornare trovando accoglienza e calore.
Il processo di slegarsi dai vecchi legami e di verifica delle sue nuove funzioni e capacità passa attraverso la realizzazione di normali esperienze di rischio. Il ragazzo può rivendicare la rischiosità delle proprie esperienze come banco di prova della nuova autonomia. Allo stesso modo l’esperienza della solitudine in adolescenza è essenziale perché il ragazzo possa scoprire il piacere della propria intimità, cui si lega il piacere di stare da solo con se stesso e con il proprio corpo, di un funzionamento mentale non più legato al concreto. In entrambi i casi è necessaria una presenza rispettosa dei genitori capaci di mantenere il giusto grado di controllo sulle azioni del ragazzo senza diventare troppo solleciti e intrusivi, senza pregiudizi verso certe esperienze che l’adolescente deve fare per poter affermare la propria personalità e per poter interiorizzare da solo i limiti, purché non siano esperienze estreme. L’eccesso di controllo può essere controproducente mentre la comunicazione che deve passare è: “io ti vedo”.
Quando il bisogno di autonomia viene rigidamente osteggiato dai genitori i ragazzi possono cercare di affermarlo con modalità estreme, come l’isolamento –anziché una normale solitudine- e la tendenza a mettersi in situazioni traumatiche –anziché lo sperimentare quote “normali” di rischio (normalmente gli adolescenti utilizzano alcune comuni esperienze di moderato rischio quali la frequentazione del gruppo di pari, la guida del motorino, sport rischiosi, vacanze all’estero senza genitori,ecc. per tranquillizzarsi circa la loro capacità di poter fare a meno dei genitori). L’eccessiva sollecitudine dei genitori può generare una eccessiva preoccupazione che può essere di ostacolo alla realizzazione di esperienze normali di solitudine e di rischio necessarie per lo sviluppo. Se l’esperienza del rischio è troppo temuta e evitata per sfiducia nelle proprie capacità, il ragazzo può chiudersi in un isolamento “patologico” che gli impedisce di personalizzarsi e di confrontarsi col gruppo dei pari, non ha modo di verificare le proprie capacità e di conseguenza può sviluppare un senso di inferiorità e un attaccamento morboso ai genitori, i quali a loro volta lamentano di avere il figlio troppo appiccicato. Questo può generare anche molta rabbia, molta ambivalenza nel rapporto genitori-foglio e molta angoscia per la separazione.
Sul versante opposto, ragazzi che si mettono in condizioni traumatiche traumatiche come assunzione di droghe, guida spericolata del motorino, furti nei grandi magazzini, promiscuità, eccetera, comportamenti spesso accompagnati dalla spavalda esibizione della loro autonomia, disprezzo per ogni cosa che provenga dai genitori, ribellione, provocazione aperta nei confronti del mondo degli adulti.
Però quando si riesce ad instaurare con questi adolescenti una relazione profonda si può verificare la presenza, a livello profondo, di un forte desiderio di protezione e di profonde angosce di separazione, da cui si difendono proprio con tali comportamenti.
I comportamenti, sia pure di chiusura o di rifiuto, esprimono sempre una richiesta di aiuto che lascia trapelare la speranza di una comunicazione vera, vitale, tenuta nascosta per paura della risposta da parte degli adulti.
E’ importante sapere distinguere fra esperienze di solitudine e di rischio che favoriscono il processo di maturazione dell’adolescente dalle varianti che lo bloccano.
Se è vero che ogni comunicazione significativa fra due persone dipende dalla capacità di sapersi mettere ognuno nei panni dell’altro e che tanto maggiore è la capacità di identificarsi tanto più vera e profonda è la conoscenza dell’altro, occorre comunque che l’altro sia disposto a farsi identificare, ma sapersi identificare con un adolescente è molto complesso. Egli infatti, non sa chi è, più che volerlo capire si può accettare questa condizione come qualcosa di naturale nel suo processo evolutivo. Solo se si è disposti ad ascoltare con interesse e con un rispetto non giudicante, se si sa accogliere le insicurezze, palesi o nascoste, l’adolescente si sentirà riconosciuto per ciò che è e che vive, questo riconoscimento gli restituisce una identità che quella di qualcuno che sta lottando per trovare un vero senso di sé.
ARGOMENTI TRATTATI
DURANTE L'INCONTRO
DEL 9 Aprile 2003
( a cura della Dott.ssa Rita Semprini - relatrice)